|

Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
A cura del dr. Giuseppe Pizzuti |
|
Arma:
inquartato,
nel 1° e 4° d’oro all’aquila imperiale austriaca, nel 2° e 3° di
nero al leone d’argento. |
|
Titoli: patrizi di Cosenza, baroni. |
|
Dimore: Corigliano Calabro, Rossano Calabro,
Cosenza e Piane Crati. |
|
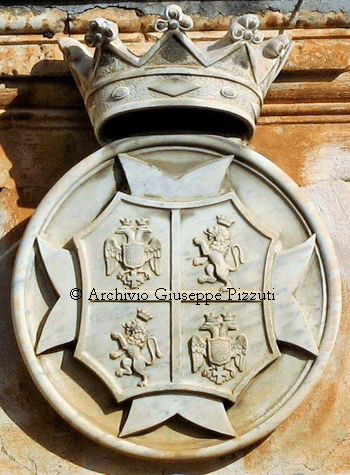
Corigliano Calabro,
palazzo Abenante, stemma |
|
Gli
Abenante giunsero in Italia, a Venezia, maestri nell'arte della
guerra, uomini valorosi in battaglia, giunsero in Calabria, a
Corigliano Calabro in provincia di Cosenza da Venosa, città
della Basilicata, nella seconda metà del XII secolo.
Nicola Abenante, frate e santo francescano, nel 1227 con
altri sette confratelli del protoconvento di Castrovillari
(comune vicino Corigliano) decisero di recarsi in missione tra
le popolazioni islamiche, i sette, guidati dal frate Daniele
Fasanella da Belvedere Marittimo, dopo aver ricevuto il consenso
dal padre provinciale Pietro Cathin
(1) con gli altri confratelli di
missione: Samuele Giannitelli, Angelo Tancredi e Donnolo
Orinaldi (di Castrovillari), Leone Somma (anch'esso di
Corigliano) e Ugolino da Cerisano; si recarono prima ad Assisi,
poi raggiunsero la Toscana per imbarcarsi verso la Spagna, qui
ricevettero la benedizione di frate Elia; raggiunta Tarrogona si
imbarcarono per il Marocco e sbarcarono a Cueta; appena le
autorità locali seppero il motivo della loro venuta in città li
fecero arrestare, furono invitati a rinnegare la loro fede, al
rifiuto vennero condannati a morte per decapitazione; furono
proclamati santi, nel 1516, da papa Leone X, al secolo Giovanni
di Lorenzo dé
Medici. |
|
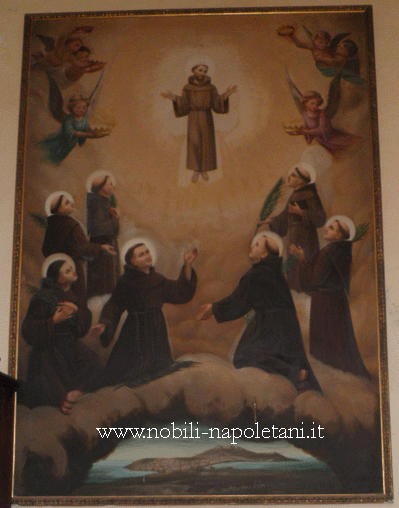 |
|
Cosenza, chiesa di San Francesco d'Assisi, i martiri di Cueta.
A seguire:
San Nicola Abenante,
martire di Cueta,
opera del pittore Guido Faita del 1971 |
|
Sertorio e Luca (de Rosis scrive Riccardo) li
troviamo al seguito di Antonio Sanseverino che si portò in
Francia per convincere
Carlo I d'Angiò (1226-1285, figlio di
Luigi VIII re di Francia) a conquistare il Regno di Napoli, il
quale mosse guerra contro Manfredi, ultimo re Svevo, e né uscì
vincitore, sconfiggendolo,
nel 1266, a Benevento; gli Abenante
furono ricompensati da Carlo I d'Angiò con la
baronia di Sarano in
terra
d'Otranto.
Baldassarre sposò la nobildonna Aurelia Pipino con la
quale ebbe: Barnaba, Andronico e Teseo, i
quali crearono tre rami: di Corigliano, Cosenza e Rossano. |
|
Piane
Crati (a pochi chilometri da Cosenza), palazzo Abenante
del ramo di Cosenza; segue la lapide è in ricordo dell'eroina
Virginia Abenante durante l'assedio del paese del
1869 |
|
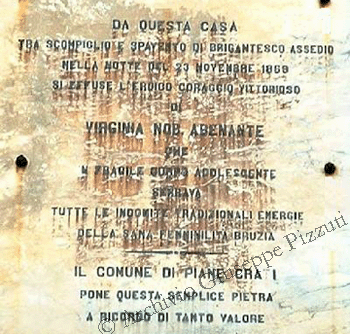 |
|
Cesare, figlio del citato Andronico, sposò Geronima de Balneis
o de Balnei di Luzzi, la quale portò in casa Abenante una
sezione del feudo Greca (l'altra
sezione era annessa al feudo di San Giovanni a Foresta),
disabitato, ubicato in
Calabria Citra, in data
11 ottobre 1481 Geronima, a mezzo di suo marito, denunciò la
morte di suo padre Bernardino de Balneis (di Giovanni), e chiese
il relevio per il feudo Greca. Pochi anni dopo, il 20 febbraio
1488, re
Ferdinando I d'Aragona detto
Ferrante, confermò alla nobildonna Geronima il feudo de Atragona
sito in Luzzi, e
l'ufficio di mastrodattia della Terra di Acri, concessioni fatta al suo avo Giovanni de Balneis con privilegio
dato in Castelnuovo di Napoli il 4 aprile 1462, confermato da
Cassano il 15 febbraio 1482. Cesare e Geronima hanno avuto come
figli, tra gli altri, Bernabeo, Alessandro, e
Nicolangelo († giugno 1558), quest'ultimo il 6 ottobre 1550
ebbe significatoria di relevio per la sezione del feudo Greca,
come erede per la morte di sua madre Geronima; agli inizi del
Cinquecento si era trasferito nella
Città Regia di
Cosenza, fu il primo che troviamo annoverato tra i nobili della Città.
Barnaba Abenante il 17 giugno 1559 ebbe significatoria di
relevio per il feudo Greca come erede per la morte di suo padre
Nicolangelo.
Il 22 novembre 1588, a Bisignano, fu stipulata una convenzione
tra Giovan Geronimo de Abenante di Cosenza, quale erede
del padre Bernabeo de Abenante e dell'avo paterno Cesare,
e Diana Abenante, notaio Giovan Domenico Montalto di
Bisignano; il 13 novembre 1589, a Bisignano, fu stipulata la
donazione di un censo da Diana Abenante di Cosenza, vedova di
Luca de
Renda, al nipote Filippo Firrao di
Cosenza, figlio di Antonino, notaio Giovan Domenico Montalto di
Bisignano; il 5 febbraio 1594, a Casale di Cavallarizzi, fu
costituito un censo da parte di Antonino Firrao e della madre
Diana Abenante, vedova di Giovan Matteo Selvaggio, su alcune
terre site nella contrada Ferramundi presso Bisignano,
notaio Giovanni Andrea Capparello di Mongrassano; il 29 ottobre
1594, a Cosenza, fu stipulata la vendita di un annuo censo su un
giardino sito nel luogo detto Muccuni di Luzzi, da parte
di Ruggero de Abenante di Cosenza ad Antonino Firrao; il
16 aprile 1616, a Cosenza, fu stipulata la vendita, al barone di
Luzzi, Cesare Firrao, di un censo e di alcuni beni siti in Luzzi,
da parte di Ruggero Abenante, notaio Patrizio Tavernese di
Rovito; il 23 aprile 1689, in Castro Creti, fu ceduto un
censo (a saldo di debito per l'acquisto di un cavallo) da parte
di Giulio Cesare Credidio del q. Michelangelo, di Fagnano,
a favore del principe di S. Agata, rappresentato dal
procuratore Ascanio Abenante, notaio Giacomo Spinelli di
Bonifati (1bis).
Nel 1726 Gennaro Abenante di Cosenza lasciò una raccolta
di dipinti: due di grandi dimensioni e tre medi rappresentanti
la storia di Susanna, San Giuseppe, Gesù e Maria, un Crocifisso,
un Sant'Antonio, una Maddalena; e ancora un quadro piccolo con
cornice dorata con l'immagine di San Gaetano, altri due, di
piccole dimensioni del SS.mo Rosario e una natura morta con
frutta. |
|
.gif)
Corigliano Calabro
(Cosenza) |
|
Il citato
Barnaba in Corigliano fece fortuna continuando a
sostenere gli interessi dei principi
Sanseverino
feudatari del grande feudo di Bisignano vicino Cosenza;
per questo motivo ottenne il feudo di Bruchetto (presso
Cassano all'Jonio) nel 1483, il feudo di Martinetto nel
1484 e nel 1485 il castello e il feudo di
Calopezzati divenendone il
1° barone. Suddito devoto
della casa regnante degli Aragonesi di Napoli non esitò
a schierarsi contro gli antichi benefattori ovvero
contro Girolamo Sanseverino (nato nel 1448) di Luca, 2°
principe di Bisignano, Gran Camerlengo, il quale aveva
capeggiato la “Congiura dei Baroni” tra il 1485 e il
1486 contro re Ferdinando (Ferrante) I d'Aragona .
Barnaba sposò la principessa Polissena di Tarsia con la
quale ebbero Ottavio e il primogenito Mario (o Mariano);
quest'ultimo alla morte del padre fece erigere un
mausoleo nella chiesa di Sant'Antonio in Corigliano con
il seguente epitaffio:
“ A Dio
Ottimo e Massimo. A Barnaba Abenante, padre molto buono,
stimatissimo in patria e fuori, signore di Calapezzati,
che i re aragonesi di Napoli, Ferdinando e Alfonso,
memori della sua devozione, fedeltà e diligenza nell'aspletamento
degli incarichi, hanno onorato di uffizi e arricchito di
molteplici privilegi, il figlio Mariano pose nel 1522
dal parto della Vergine”. |
|
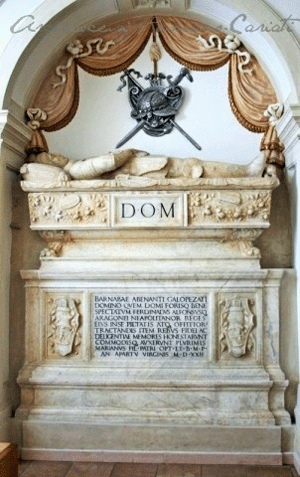
Corigliano Calabro,
Chiesa di Sant'Antonio, sepolcro di Barnaba Abenante
Foto tratta dal sito dell'Arcidiocesi di Rossano
Cariati |
|
Mario,
2° barone di Calopezzati,
cavaliere di Malta, servì con fedeltà Carlo V il
quale gli confermò il titolo e i feudi posseduti,
inoltre, per fronteggiare le incursioni dei turchi gli
affidò l'incarico della guardiania dei porti e delle
spiagge della
Calabria Citra e
Ultra. Nel 1525 fu investito per ordine del vicerè
don Pietro Consaga della
baronia di Casabona e di
S. Morello per aver
sedato le rivolte della popolazione contro l'eccessiva
fiscalità spagnola; le citate baronie, erano state
devolute al fisco per la fellonia
(2)
di Scipione e Diomede
Antinori; inoltre, nel 1528 fu investito dal vicerè
don Pietro de Calon anche del feudo di
Zinga e
Massanova, devoluti al
fisco per il delitto di fellonia dai crotonesi Giovanni
Pipino e Ferrante Materdoni.
Mario fu un valoroso combattente, si distinse nella
battaglia di Siena e in quella del Ticino nel 1532
nella quale lo colse la morte; sposò Eleonora
de Gennaro, contessa di Martirano ed ebbero:
Bernardino,
fu cavaliere di Malta,
Alessandro
e il primogenito
Pietro Antonio.
Il citato Pietro Antonio Abenante divenne il 3° barone
di Calopezzati
(2bis); sposò la nobile napoletana Laura
della Tolfa, con al quale ebbero:
Claudia,sposò
Tiberio
Barracco,
Lelio,
Ottavio,
Mario,
generale dell'armata spagnola sotto le mura di Barletta,
ed il primogenito frà
Marzio,
cavaliere di Malta, priore di Santo Stefano in Pisa e
ammiraglio della flotta.
Pietro Antonio ottenne diversi incarichi da Carlo V, fu
condottiero valoroso, si distinse nell'assedio di
Catanzaro nel 1528 contro le truppe francesi guidate
dal generale Lautrec; partecipò alla
spedizione di Tunisi al seguito dell'imperatore.
Successivamente fu nominato capitano d'armi di Rossano
da
Carlo V e da sua moglie Bona, regina di Polonia
principessa di Rossano, con ordine di fortificarla e di
munirla di vettovaglie perchè si temeva un attacco dei
turchi, in questa occasione fu restaurata porta Melissa
e le venne dato il nome di Bona con la seguente
iscrizione: “Quincti
Caroli Cesaris invicti fedelitati, Bonaeque Poloniae
Reginae urbis Principessae Antonius Abenantius
Hipsicronis Calopetiatique Dominus dicavit, et quae olim
Melissa vocabatur postae ex principessae nomine Porta
Bona nuncupuri jussit. An. 1552.”
Nel 1543, Pietro Antonio fu investito del
feudo di Cirò,
smembrato dalla contea di Santa Severina a causa delle
difficoltà economiche di Galeotto
Carafa,
2° conte di Santa Severina, ed acquistato dal suo
prestanome o procuratore Raffaele
de Mari,
da questo momento iniziò un periodo nefasto per tutta la
sua famiglia, la popolazione si dimostrò ostile in
quanto non volevano essere infeudati, inviò sua moglie
con un numeroso seguito a prenderne possesso ma, la
popolazione si sollevò in armi tanto da non permetterle
di entrare in città e fu costretta a rifugiarsi nel
vicino convento di San Francesco d'Assisi fuori le mura.
In seguito ci furono aspre lotte ed il barone Pietro
Antonio fu costretto ad essere molto duro con la
popolazione; vi fu lo scontro anche con il clero locale
che riteneva il feudatario colpevole di ingerenze e
soprusi tanto da essere accusato presso il Santo Uffizio
di eresia, bestemmia e altri reati; subì l'arresto e fu
condannato dal tribunale della Santa Inquisizione di
Roma per eresia; da questo momento non si seppero altre
notizie sul suo conto né la data di morte. Furono
colpiti anche i suoi figli di analoghe accuse, costretti
a rendersi irreperibili, furono condannati in
contumacia.
Nel 1569, Giovan Vincenzo
Spinelli,
figlio ultrogenito di Ferrante, 2° duca di
Castrovillari, a mezzo di sua madre, Isabella
Caracciolo,
acquistò i feudi di Cirò e Calopezzati con la bagliva e
la mastrodattia
per la somma di 35.000 ducati, messi all'asta dal Sacro
Regio Consiglio su istanza dei creditori di Pietro
Antonio, seguì il regio assenso il 22 dicembre 1571. |
|
 |
|

Stemmi su dipinti commissionati dalla Famiglia |
|
Eleonora Abenante, nata a Corigliano nel 1689;
ricordata per il suo ardore verso la fede cristiana e il
suo zelo per l'opera caritatevole istituita nel 1607
dalla sua famiglia ovvero del “Monte di maritaggio”,
attraverso il quale annualmente, il 10 di ottobre,
giorno in cui si festeggia San Nicola Abenante,
la famiglia si impegnava a costituire la dote a due
donne vergini bisognose e prossime alle nozze; altra
opera pia fu istituita dagli Abenante presso la
parrocchia di San Pietro a favore di otto ragazze povere
estratte a sorte su un numero di venti e vestite nella
sagrestia.
Eleonora sposò Giovanni Leonardo Oliviero di Cutro
(Crotone), anche ai suoi figli insegnò la carità
cristiana.
Giovan Battista figlio della citata Eleonora,
sacerdote, erede universale dei beni della famiglia
Oliverio in Corigliano, Cutro, Crotone e Rocca Bernarda,
istituì, nel 1783, il “Monte dei poveri di Gesù Cristo”,
la più alta e benefica istituzione privata creata nei
secoli in Corigliano.(3) |
|
.gif)
Rossano Calabro (Cosenza) |
|
Teseo Abenante di Baldassarre e fratello di Barnaba decise
di investire acquistando grandi latifondi per destinarli
alla coltura di arboree e orticole su vasta scala, ben
presto diventarono, a metà del Cinquecento una delle
famiglie più ricche di Corigliano; questa espansione si
prolungò anche nella vicina Rossano in quanto presentava
le stesse caratteristiche di terreno, nella prima metà
del Seicento riuscirono a radicarvisi come imprenditori
agricoli con
Orazio
e Lelio († 7 settembre 1668), con atto del 17
giugno 1662 acquistò da Dionora Morgia il
Casale di Joggi in
Calabria Citra, pertinenza della baronia di Malvito sin
dall'epoca
Angioina (oggi frazione di Santa Caterina Albanese in provincia di
Cosenza); Cesare Abenante il 26 ottobre 1669 ebbe
significatoria di relevio per il Casale di Joggi, come
erede per la morte di suo padre Lelio, vendette il
Casale ad Angelo Jordanello di Cetraro per la somma di
ducati 14.400 con Regio Assenso del 21 febbraio 1681, lo
rivendette appena due mesi dopo ad Antonio
Ametrano, 1° duca di San Donato. Nel 1669, Isabella, moglie di Lelio, aveva
acquistato a nome dei figli la
tenuta di Volimento in Rossano.
Orazio sposò la nobile Cherubini che gli portò in dote
anche delle proprietà terriere, ma, nel giro di pochi
anni, morirono i tre figli, per questo motivo Orazio
fece testamento a favore dei nipoti, figli di Lelio: Ottavio,
Cesare,
Barnaba e Federico;
gli ultimi tre si occuparono dell'attività
imprenditoriale, trasportavano per conto proprio verso
il porto di Napoli ciò che producevano, Barnaba fu
stabilmente a Napoli per curare gli interessi, ben
presto, a causa del suo alto tenore di vita, causò
problemi finanziari in famiglia, lo colse la morte
lasciando 3.600 ducati di debiti ed un figlio, Lelio (1702 † 1765),
gli zii riuscirono a ripianare i debiti e Lelio ingrandì
con profitto l'attività, sposò la patrizia di Rossano
Serafina Malena con la quale generarono sedici figli;
dei cinque maschi solo tre si occuparono delle attività
a tempo pieno ovvero Barnaba, Emanuele e Gaetano;
saltuariamente Paolo,
che diverrà avvocato in Napoli, e Francesco.
Barnaba divenne il capo famiglia, fece educare tutti i
suoi fratelli, diede un nuovo assetto finanziario alle
attività, con i suoi fratelli promosse un'azione
giudiziaria dinanzi alla Real Camera di Santa Chiara per
ottenere la reintegra nel Seggio di Cosenza, la sentenza
ebbe esito positivo, in molti atti notarili è appellato
come patrizio di Cosenza; nel 1781 partecipò alla
vendità all'incanto del feudo di Monastarace contro Domenico Perrelli, 4° duca di Monastrace, a causa di
alcune vicende giudiziarie prese intestazione il 28
ottobre 1787, seguì il Regio Assenso il 17 gennaio 1791;
si trasferì a Napoli per meglio gestire gli interessi di
famiglia e lasciò Emanuele in Calabria; quest'ultimo,
sposato a Maria Francesca Giannuzzi
Savelli dei principi di Cerenzia, fece degli
investimenti in latifondi su tutta la costa Jonica tra
le province di Cosenza e Crotone, ma anche dal punto di
vista edilizio, il più significativo fu la
realizzazione del “casellone per comodo de' marinati”
l'attuale “Casello Martucci”; la masseria nei primi
anni dell'Ottocento si presentava con un corpo di
fabbrica accresciuto sull'antica torretta, un concio per
la liquirizia, una cappella, magazzini per il grano, la
forgia, le stalle, il forno, casette per il personale;
le produzioni primarie nella masseria furono: olio,
liquirizia e sapone esportati nel Regno ma anche a
Livorno, Genova e Lisbona. |
|
 |
|
Rossano Calabro (CS), Arco d'ingresso del Teatro Nazionale.
A seguire:
Rossano Calabro (CS), Palazzo Amarelli già Abenante |
|
 |
|
Barnaba decise di restare celibe, si concentrò nel
gestire l'impresa di esportazioni in Napoli,
responsabilità accresciuta anche dal fatto che tutti gli
altri fratelli rinunciarono alla loro parte dell'asse
ereditario, tranne l'ultimo fratello, Gaetano,
cavaliere, sposato con Concetta de Mauro.
La rivoluzione
del 1799 causò notevoli perdite, sia perchè i debiti
non furono più esigibili (anche a causa di morte nella
rivoluzione), drastica diminuzione delle attività
economiche ma, anche perchè Emanuele ne fu protagonista
attivo parteggiando per i rivoluzionari, tanto da essere
nominato presidente del comitato provvisorio
repubblicano, questo gli costò il sequestro di alcuni
beni, subì il carcere, riuscì a salvarsi con atto di
pentimento, anche Gaetano fu costretto a rifugiarsi a
Roma; inoltre nel 1802 Barnaba morì, l'amministrazione
delle attività fu gestita in due sedi per cui a Rossano
rimase Emanuele, a Napoli curò gli interessi Gaetano
dando vita nel 1804 ad una nuova società mercantile; ma
la crisi fu irreversibile, il figlio di Emanuele, Lelio,
morì a soli dodici anni il quale era stato nominato
erede universale dallo zio Barnaba; Gaetano accumulò
70.000 ducati di debito e fu costretto a riparare a
Rossano tanto che nel 1810 la società andò in crisi e
lasciò una strascico finanziario per diversi decenni;
nel 1813 Emanuele rese l'anima a Dio lasciando eredi le
tre figlie femmine sposate con altrettanti nobili
rossanesi e i beni confluirono in queste casate: Serafina sposò
Nicola Falco, Maria Rosa sposò Pietro Antonio
Toscano nel 1823, rimasta vedova nel 1830, sposò in
seconde nozze Raffaele de
Mauro; Nicoletta sposò Fabio Martucci,
ai quali verrà successivamente assegnato dal tribunale
la masseria del Casello dalla quale per molti decenni
(fino alla seconda metà del Novecento) uscirà la famosa
liquirizia Martucci
(4).
Il ramo si estinse in Rossano ma continuò a fiorire in
Napoli con Francesco Abenante dei baroni di
Calopezzati.
In Napoli gli Abenante possedevano una cappella
gentilizia che nel 1545 fu acquistata da Cosmo Pinelli.
Altri Cavalieri di Malta della famiglia furono:
Giovanni Battista, di Napoli, ammesso il 12 aprile
1578, Gran Croce e capitano di galera, colonnello della
fanteria di Carlo V, militare valoroso, ebbe la
concessione dell'insegna gentilizia nella quale figurano
due aquile austriache e due leoni; Pompeo, di
Cosenza, ammesso nel maggio del 1548; altro Pompeo,
di Cosenza, ammesso il 2 maggio 1576, fu capitano di
galera
(5).
|
|

Napoli, Cappella Abenante |
|
Di seguito: Albero genealogico della famiglia Abenante,
si noti in basso, seduto ed appoggiato all'albero il
capostipite Santoro (che possiamo identificare in
quel Sertorio come indicato in altra fonte), il
quale ci sta indicando l'antica arme di famiglia;
accanto, nel tondo, è raffigurato San Nicola
martire; a destra, nel cartiglio, sono indicati gli
autori, che nel tempo, hanno scritto sulla famiglia
Abenante. In alto, l'ultimo esponente è il Colonnello
Mario, sposato ad Eleonora de Gennaro, sepolto in
San Domenico a Napoli. |
|
___________________
Note:
(1) - Beato, compagno di San Francesco d'Assisi,
costruì il primo convento francescano in Calabria, nel 1220, a
Castrovillari e ivi morì, nel 1264, per mano degli ebrei del
luogo.
(1bis) -
Mario Pellicano Castagna “La Storia dei Feudi e dei Titoli
Nobiliari della Calabria” Vol.II pag. 326.
-
Ministero dell'Interno, pubblicazione degli Archivi di Stato XI,
Archivio di Stato di Napoli, Archivi Privati, Vol. I seconda
edizione, Roma 1967, Archivio Sanseverino di Bisignano:
205-207-216-218-270-271-357.
(2) - Nel diritto feudale era il delitto tradimento degli
obblighi esistenti tra il signore feudale e il suo vassallo,
giurati durante l'investitura; il reato veniva punito con la
confisca del feudo che veniva restituito al sovrano.
(2bis) - Mario Pellicano
Castagna scrisse che il possesso del feudo di Calopezzati non si
ebbe per successione tra Mario e suo figlio Pietro Antonio, in
quanto dopo Mario risulta possessore Pirro Antonio
Crispano († 6 agosto 1550), patrizio napoletano,
barone di Casoli e Chianca, suo figlio Giovan Vincenzo il 3
agosto 1551 ebbe significatoria di relevio per le terre di
Casoli e di Chianca, ed anche per la terra di Calopezzati in
Calabria Citra, come erede per la morte di suo padre. Pietro
Antonio
Sanseverino,
principe di Bisignano, lo stesso anno risulta rientrare in
possesso del feudo di Calopezzati, che lo rivendette subito a
Paolo
Caselli nel 1551, quest'ultimo lo cedette a Pietro
Antonio Abenante barone di Cirò. Mario Pellicano Castagna “La
Storia dei Feudi e dei Titoli Nobiliari della Calabria” Vol.I
pagg. 344-345.
(3) - Enzo Cumino in “Veteranova” Anno I N.° 5, giugno/luglio
2013.
(4) -
Mario Pellicano Castagna “La Storia dei Feudi e
dei Titoli Nobiliari della Calabria” Vol.II pagg. 347-348. Luigi
Piccioni “Sulle attività economiche degli Abenante di Rossano
nel Settecento dall'archivio Abenante-Martucci di Rossano
Calabro”, in “Daedalus”, 2006.
- Luigi Piccioni “Sulle attività economiche degli Abenante
di Rossano nel Settecento dall'archivio Abenante-Martucci di
Rossano Calabro”, in “Daedalus”, 2006.
(5) - L'Araldo “Almanacco Nobiliare
del Napoletano 1896”, Enrico Detken, libraio editore, Napoli
1895, pag. 259. |
|
Bibliografia:
- Egidio Mezzi in “Calabria Letteraria” n.ri 10-11-12
del 2001 - Rivista edita da Rubbettino.
- Frà Girolamo Sambiasi “Ragguaglio di Cosenza e di
trent'una sue famiglie nobili”- Napoli MDCXXXIX.
- Cav. barone Luca de Rosis “Cenno
storico della città di Rossano e delle sue nobili
famiglie” - Napoli, 1838.
-
Alessandra Anselmi "Collezionismo e
politica culturale nella Calabria vicereale borbonica e
postunitaria" - Gangemi Editore. |
|
Sitografia:
-
https://www.beweb.chiesacattolica.it/benistorici/bene/3500552/Maestranze+napoletane+%281796%29%2C+
Stemma+ Famiglia+ Abenante+12 |
|