|

Ovvero delle Famiglie
Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili
di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti
alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate
chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che
abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.
|
|
 |
Famiglia
d'Alessandro |
|
Giovanni
Giuseppe, nato a Pescolanciano il 25 marzo 1656, terzogenito del duca
Fabio Junior, successe al fratello Geronimo morto prematuramente(1).
|
|

© Incisione
del ritratto del duca Giuseppe |
|
Egli in data 4 giugno 1689,
con decreto di preambolo della
Gran Corte della Vicaria
(2),
venne dichiarato erede universale da testamento, rivestendo il
titolo di VIII barone e III duca dei vari feudi e beni burgensatici
costituiti da: "Peschiolanciano", "Carovillari", Castiglione,
Civitanova, Civitavetere, Valle, Cocozzoli, Roccalametta,
Schenaforte. A queste località si aggiunsero, infine, i paesi di (Roccaraso),
Castel del Giudice(3),
Roccacinquemiglia e Vicennapiane, ereditati con il matrimonio
contratto nel 1686 (alcuni autori riportano la data del 1675) con
la cugina, Anna Maria Baldassarre Marchesani, figlia del barone
Gio. Tommaso Marchesani (“famiglia di probabile origine salernitana”)
e Margherita d’Alessandro,
sua zia paterna(4).
Giuseppe, uomo
all'antica, visse preferibilmente nel feudo di Pescolanciano
(nonostante i continui spostamenti a Napoli per i molteplici
impegni) con tutta la sua numerosa famiglia, dedicandosi ad attività
tramandata tra i d'Alessandro quale la cura e l'allevamento di
cavalli.
Dedito a queste “gran professioni di cavallo e spada”
mantenne e si attenne a quei simbolici, leali valori ideali
provenienti dalla tradizione cavalleresca, ormai in fase di
dissolvimento sul finire del XVII secolo
(5).
Ciò spiega, tra l'altro, il suo interessamento
per il riassetto delle pertinenze del castello, sistemandovi
scuderie, stalle i cui ambienti si presentano ancora di rilevante
dimensione.
|
|
Gli
abbellimenti del maniero riguardarono anche l’arredamento che si
arricchì di una
galleria di quadri firmati (circa 209).
Lo
stesso continuò
altri lavori nel maniero e di ciò non pago, donò nel
1696
alla chiesetta del San Salvatore, nel borgo di Pescolanciano, una
sua cappella privata sottostante il castello promovendo e
partecipando all'ampliamento strutturale di detto luogo sacro, a
prova della sua devozione alla fede cristiana. |
|
Questo evento viene ricordato dalla lapide
posta sul portale della suddetta chiesa(6):
|
|
D. O. M.
HAS VALVAS CUM SCALA,
EORUMQUE CONTENTA:ET ECCLESIAE
SPECIALIORA,
VERUM ETIAM ANNOSUM CASTELLUM SUAM CAPPELLAM
ADIUNGERE,
RESTAURARI FECIT
D. IOSEPH DE ALEXANDRO
DUX PESCHILANCIANI
NON SINE AMPLIATIONE REFACTIONE ORNAMENTO DICTAE TERRAE BREVI
TEMPORE EIUSDEM VI CLAUSAE AC TERMINATAE
ANNO DOMINI M.C.L.XL.VI
VITAM DE GENTE P.INNOCENTIO XII CAROLO II REGE EPISCOPO
IN HAC
DIOCESI
F.ANTONIO TORTORELLI. |
|

© Pescolanciano-
chiesa di S. Salvatore con portale e lapide marmorea
soprastante a ricordo del Duca |
In
questo periodo Giuseppe risulta occuparsi dell’ordinamento erariale
e della organizzazione governativa dei suoi feudi. Nel 1691, ad
esempio, fu stabilito un sistema di pagamento/riscossione di dazi su
alcune terre.
Mentre nel feudo di Sprondasino, sul ponte omonimo sembra essere
stata collocata lapide relativa ad un editto di
re Carlo II, su cui
veniva sancito quanto segue(7):
"PANETTA SEU TARIFFA DELLI DERITTI DEL PASSO DI
SPERONASINO DELL’ILLUSTRE DON GIUSEPPE D’ALESSANDRO DUCA DI
PESCOLANCIANO. PER QUALSIVOGLIA SALMA DI ROBBE, MERCANZIE DI
QUALSIASI SORTE E VALORE CHE PASSA PER DETTO PASSO, GRANO UNO E
MEZZO PER QUALSIASI PERSONA A PIEDI ED A CAVALLO GRANO UNO E MEZZO.
PER CENTENARO DI PECORE, CASTRATI, PORCI, CAPRE ED ALTRI ANIMALI
MINUTI GRANA 25, E SE SARANNO DI MAGGIORE O MINOR NUMERO SI PAGHERA’
PRO RATA A DETTA RAGIONE PER CENTINARO, PERO’ SE DETTI ANIMALI
SARANNO DEI LOCATI DELLA REALE DOGANA, SI ESIGGA SOLAMENTE A RAGIONE
DI UN CARLINO PER MORRA E NON PIU’. SENZA PREGIUDIZIO PER L’IMMUNITA’
PRETESA PER LI LOCATI PREDETTI. PER CENTINARO DI ANIMALI VACCINI ED
ALTRI ANIMALI GROSSI CHE PASSERANNO PER DETTO PASSO, CARLINI 5 E SE
SARANNO DI MAGGIORE O MINOR NUMERO SI PAGHI PRO RATA A DETTA REGIONE
DI DENARO. DATUM NEAPOLIS EX REGIA CAMERA SUMMARIA, DIE 20 OCTOBRIS
1691 D. SEBASTIANO DE CORTES, ANDREAS GUERRERO DE TORRE, SCUS
IANUARIUS CECERE ACTERARIUS."
Il
primo agosto 1695 fu spedita significatoria di ducati 23.1.10
(23.110) per la morte del fratello Geronimo
avvenuta nel 1689, vedendolo così impegnato nelle pratiche
successorie.
|
|
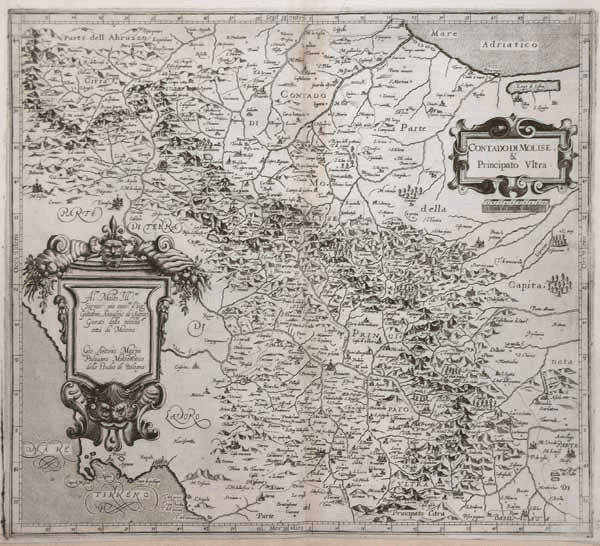
©
Mappa
del Contado di Molise all'epoca del Duca con i Feudi dei
d’Alessandro
|
|
Qualche anno dopo, nel 1704, invece lo stesso ordinò l’incisione di
tutti gli alberi esistenti nel feudo di Civitanova per dimostrare
il proprio possesso su questi boschi e terreni (Scandiglieri,
Forconi, Monticello, Selvapiana, Spelonca, Castelluccio,
Pescovenafro) contese dal comune di Civitanova, onde far valere i
propri diritti dominicali(8).
Oltre alle continue e numerose liti giudiziarie, il duca Giuseppe fu
impegnato nella gestione fruttifera del patrimonio feudale.
Documenti datati 1695, 1696, 1697 e 1704 testimoniano l’esistenza di
affittanze anche degli erbaggi per il pascolo sui feudi rustici di Scandiglieri e Spronasino.
Egli, tra l’altro, si interessò ad alcune proprietà locali.
Possedeva, ad esempio, lungo il tratturo che allora costeggiava
l’esterno dell’abitato di Pescolanciano un fabbricato denominato
“Taverna del duca”, luogo per la sosta e ristoro di forestieri in
transito nel paese e degli addetti alle greggi, durante i periodi
della transumanza. Inoltre, poco lontano e fuori dal borgo, sorgeva
la “Casina del duca” (in prossimità dell’attuale ferrovia) ove si
radunavano i partecipanti alle battute di caccia organizzate dal
feudatario.
Altresì, pure due mulini funzionanti ad acqua, siti nelle vicinanze
da quell’abitato (uno vicino alla zona dell’attuale cimitero in
Pescolanciano e l’altro prossimo al bosco di S. Onofrio, attiguo ad
una fonte di acqua sorgiva ora sfruttata per altri scopi), che
dovettero appartenere all’amministrazione ducale con tanti altri
mulini sparsi nei vari feudi.
Oltre
a questa immagine di aristocratico attivo ed operoso nella gestione
del patrimonio feudale, si rinvengono altre notizie storiche circa
la presa di posizione del duca nei confronti della società spagnola
in auge a quel tempo. All’oppressiva, corrotta, inefficiente
dominazione spagnola nel Vice-Reame di Napoli, sempre più gravato da
tasse, il duca Giuseppe opponeva un atteggiamento critico,
conservatore, di reazione.
Manifestò pubblicamente questi suoi sentimenti contrari verso
aspetti della vita ed usanze deplorevoli, comuni agli invisi
dominatori. In una quartina della sua opera biasimò, perfino, l’uso
iberico del “Don” praticato dai cavalieri napoletani. Scrive
all’uopo il duca Giuseppe: |
“Circa
il don praticato dai cavalieri…
altro non è che un donativo
che, molt’anni non ha, l’Iberia fece
Ai nobili d’Italia, e questi in vece
Gli dier saluti col superlativo”.
|
|
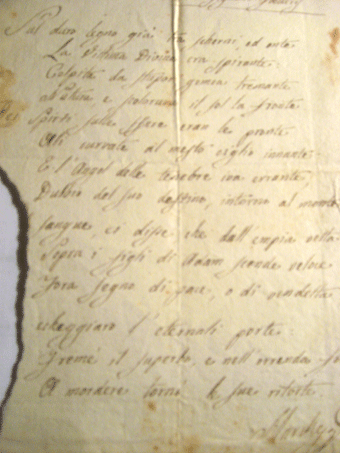
© Poesia manoscritta del Duca
|
In questo periodo finale del 1600, trovandosi a Napoli (ove
alloggiava nella sua sontuosa
dimora sita in via
Nardones-Sant’Anna di Palazzo, zona via Toledo) egli venne
arrestato e fatto imprigionare in Castel Nuovo, perché
sospettato di partecipazione e coinvolgimento in una
congiura
anti-spagnola (congiurati di Macchia-1705).
Il d’Alessandro, in alcune sue rime autobiografiche
pubblicate nella postuma opera “Selva Poetica”, si difese sostenendo di
essere stato vittima di un’invidiosa calunnia: “(…)da l’invidia
a tal segno io son ridotto”.
|
|
Durante quell’infausto periodo della prigionia nacquero altri
figli, oltre ai cinque già in vita, tra cui il secondogenito
maschio Consalvo ed Antonio. Unico conforto per il nobile
personaggio, rinchiuso nelle carceri, restò -oltre alla lettura
di libri- quello di contemplare le bellezze naturali, che lui
riusciva a scorgere dalla sua cella sita nel suddetto castello
angioino. Suoi sono questi versi, tratti dalla “Selva Poetica”:
“Questa stanza felice altresì rende
Del mar la leggiadrissima veduta
Vicin’è il porto, e godo se l’occhiuta
Sua rete il pescator raccoglie e stende”
|
|
Nel 1707 il duca fu liberato dalla prigione e graziato dal
maresciallo conte di Daun,
comandante delle truppe ispano-asburgiche, insediatesi
vittoriosamente in Napoli. Nuovamente, tuttavia, dopo poco tempo
egli si trovò ancora ad assaporare l'amarezza di essere
imprigionato proprio dallo stesso
Viceré Daun per
altre implicazioni (sembra, forse, derivanti dalla sua opposizione
ad imporre nuove gabelle verso la popolazione anche nei suoi feudi). Comunque, grazie all'intervento successivo del generale Heindel(10)
ed alla difesa eloquente del giurista Giuseppe Sparano, suo
difensore,
il malcapitato feudatario riuscì a venir fuori da tali intricate
vicende ed ottenere finalmente la libertà. Ciò malgrado
nell’agosto del 1712, dimorando il duca Giuseppe con i propri
familiari nel castello in Pescolanciano, visse fastidiose
traversie ad opera dell’Autorità asburgica (intervenuta colà con
scorta di soldataglia tedesca al comando del Real Consigliere
Francesco Condè), che tentava di ridurlo in cattività.
Egli
allora, per sfuggire alla cattura, risulta che trovò rifugiò
nella locale chiesa, fruendo del dritto di asilo.
In quel subbuglio, la sua famiglia sotto la guida del figlio
Ettore si trasferì all’improvviso ad Isernia. |
|

© Ritratto pittorico del Duca Giuseppe |
|
Il duca però sotto
la minaccia dell’arrivo di ulteriori rinforzi, si decise allora
a lasciare il sacro luogo, ma venne obbligato dagli alemanni ad
allontanarsi immediatamente dal suo feudo. Condotto dai suoi
“seggettari”, benchè malfermo in salute, egli affrontò questo
forzato e pericoloso trasferimento raggiungendo in giorni
diversi la terra di Sessano e poi di Carpinone, concludendo il
suo viaggio a Pettorano, dove si aggravò la sua malattia.
Contemporaneamente, si ritirarono dal luogo anche le truppe
imperiali. Questo episodio potrebbe essere scaturito dai
sospetti che, talora, l’amministrazione straniera nutriva sulla
scarsa fedeltà del duca verso l’asburgico dominio(11).
In seguito poté dedicarsi nuovamente ai suoi studi ed
esperienze per i cavalli, giungendo a sintetizzarli con il primo
capolavoro. Nel 1711, presso la tipografia di Domenico
A. Parrino, Giuseppe d’Alessandro faceva pubblicare il suo lavoro
"Pietra di Paragone dei Cavalieri" o “Arte del Cavalcare”.
Tale
componimento scientifico-letterario fu il prodotto di conoscenze
teoriche e di esperienza pratica dell’autore, dedito
all’attività equestre fin da giovane età. In quanto cresciuto,
come lo stesso ricorda in una pagina di detta opera in occasione
di una ricostruzione sommaria della sua ascendenza, nel contesto
familiare ove la tradizione ippica era ben consolidata e
affermata, sin dai tempi dell’antenato Fabio Senior
(12),
vissuto nel XVI secolo.
Fu
suo padrino, tra l’altro, il cavalier napoletano Cesare Frezza,
il quale viene ricordato nell’opera “Arte del Cavalcare”.
Ma
fu soprattutto lo zio paterno, il cavaliere Giovanni, a
trasmettergli la sentita passione per i cavalli. Costui allevò
ed addestrò una razza di cavalli “saltatori”, molto richiesti
dai nobili cavalieri del tempo.
Tutti familiari longevi poiché, come scrive il
d’Alessandro, praticavano “ l’esercitio di cavalcare e della caccia ”.
Il
duca Giuseppe, comunque, al tempo della pubblicazione era “(…) ben
noto nella cerchia della nobiltà meridionale, che aveva in pregio
ideali e professioni cavalleresche d’antico stampo”(13).
In proposito il
d’Afflitto scriveva, sul finire del XVIII
secolo, nella sua opera: “Memorie degli scrittori” “(…) ho inteso
a dire da’ nostri vecchi cavalieri, che nelle contese di spada,
e del merito di un cavallo, a Lui come ad oracolo si ricorrea”(14). Non fu l’unico erudito, di lui contemporaneo, a ricordarlo quale
noto scrittore di cose cavalleresche. Viene fatta menzione del
d’Alessandro e della sua opera anche dal Gimma e dal
Mazzucchelli.
Questa ben diffusa conoscenza tecnica equestre, frutto della
personale esperienza nel suo feudo di Pescolanciano, fu
supportata da un’insieme di nozioni accademiche di influenza
letteraria barocca, acquisite dal duca negli anni della sua
formazione. Fu, così, ispirato da quella “fastosa iconologia
secentesca dei cavalli”
che ebbe le massime espressioni nel Preti, in Antonio Bruni e
soprattutto in
Giambattista Marino.
Il duca Giuseppe, molto
legato alla corrente poetica del Marino, espresse “(…)con una
poetica barocca quella iconologia dei cavalli, con un amore
quasi sensuale che fu comune a diversi autori nel 600”.
Nell'opera diversi sonetti e madrigali (forma
poetico - musicale, nata a metà del trecento, destinata ad ambienti
colti e raffinati dell’epoca. Vedi
Gesualdo)
inneggiavano ed esaltavano le glorie e virtù del cavallo. Egli, però, non si limitò a poetare sul nobile
quadrupede (significativi i sonetti dedicati “Al Cavallo” o “Ad un
velocissimo e nobile Cavallo”), ma espresse anche opinioni polemiche
contro l'agonizzante filosofia astratta delle scuole di tendenze
“crepuscolari”(con uno schema formale e sillogistico del mondo e
della vita) esaltanti “l'ente di
ragione”, molto diffuse in Napoli, a quell'epoca. |
|
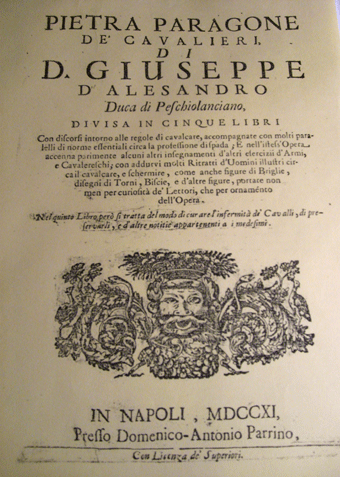 |
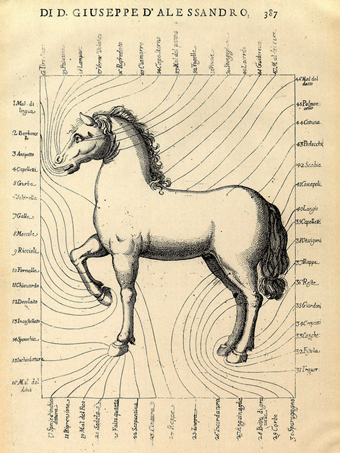 |
|
©
Prima edizione opera
“ARTE DEL CAVALCARE”
(Anno 1711). A destra: © IMMAGINE DESCRITTIVA
SULLO STUDIO ANATOMICO DEL CAVALLO,TRATTO DA “ARTE DEL CAVALCARE” |
|
Il
d’Alessandro, inoltre, doveva ben conoscere una serie di
importanti trattati di illustri accademici, a lui contemporanei
o vissuti in epoca precedente, i quali scrissero
sull’equitazione, sul maneggio, sull’anatomia e malattie del
cavallo. Alcune opere compaiono, tra l’altro, nell’inventario
del 1715, redatto a morte del Giuseppe d’Alessandro.
Vi compare, in ordine cronologico di data di edizione, il libro
di Rusio(15),
del Corte(16),
del Liberati(17),
del Santapaulina(18).
Alcune di queste fonti compaiono, poi, tra gli autori citati nel
secondo libro dell’opera.
Il cavallo, argomento ispiratore dei cinque libri componenti la
“Pietra di Paragone”, venne studiato nelle sue variegate
componenti come per lo più attuato in altri trattati ippici. Del
resto il cavallo rimaneva ancora per tutto il XVII e XVIII
secolo l’animale necessario all’uomo per i suoi spostamenti e
per i combattimenti durante le guerre, come testimoniato
nell’opera. Questa è pertanto così composta e divisa:
Nel libro primo, vari capitoli si alternano dopo che l’autore,
rivolgendosi ai “Baroni del Regno”, motiva tale suo sforzo
letterario:
“Ho cercato fare con la penna non senza gran studio qualche
piccolo giovamento a vostri figli, ed a i posteri loro
ch’emulando la virtù de loro Genitori, e de loro Avi cercano in
quest’onorato mestiero a buon segno avanzarsi”.
Nel capitolo 1° del suddetto libro la disquisizione verte sulle
modalità di stare a cavallo, mantenendo una certa equilibrata
posizione sulla sella, con i piedi ben nelle staffe e sull’uso
degli speroni. Precise indicazioni sono poi date nella fase di
montare in sella.
|
|
Nel 2° capitolo intitolato “Degli aggiuti e
castighi” si insegna al cavaliere l’uso appropriato di parole,
con varie tonalità e termini fonici, per incitare o ammonire il
cavallo allo scopo di abituarlo a precisi segnali. Si passa poi
ad un (III) capitolo, ove emergono precise regole su come
“preparare la bardella, e sbardellare i polledri”. Consigli
sull’addomesticamento dell’animale con l’utilizzo del “capezzone
senza briglia”(19),
del “nerbo e bacchettone” per abituarlo all’andatura, alla museruola
(da ungerla di miele per farla meglio accettare dal puledro). Il duca Giuseppe, poi, passò a descrivere nel capitolo IV la fase di posizionamento della sella, delle redini e morso
sul puledro, da ammaestrare. Infine, come da insegnamenti
ricevuti dal maestro dell’autore, Carlo Christallino, venne
trattata la salita in sella del cavaliere, il controllo del
cavallo con bacchetta, le redini e gli speroni: argomenti questi
del V capitolo. |
|
Il secondo libro è invece improntato ad affrontare l’attività o
“mestiere dell’imbrigliare”, partendo da una rassegna di
contributi letterari sull’argomento ricavati da “antichi
autori”. Rifacendosi a costoro, il d’Alessandro intese darne
ulteriore aggiornamento con un suo contributo.
I personaggi citati, con riferimento alle loro specifiche opere
ippiche, appartengono a varie epoche e provengono da varie
regioni d’Italia. Si parte da Gio. Battista Galiberti, da
D. Giovanni Gamboja cavaliere napoletano, Lorenzino Palmieri
cavallerizzo fiorentino del Gran Duca di Toscana, Cesare Fiaschi
nobile ferrarese, Federico Grisone cavaliere napoletano, Antonio
Pirro “ferraro” napoletano, per finire a Diego Cardua ed altri.
A conclusione di detto libro furono inserite delle osservazioni
“sopra la cavalleria, effetto, e giustezza della briglia
Ginetta”.
L’autore conclude con sue osservazioni e suggerimenti anche
contrari ai postulati, espressi dagli accademici chiamati in
causa.
L’autore conclude con sue osservazioni e suggerimenti anche
contrari ai postulati, espressi dagli accademici chiamati in
causa.
Il terzo libro contiene 92 tavole, su cui sono incise figure di
“briglie” e di “guardia” con rispettive spiegazioni. Il quarto
libro, invece, è diviso in due parti. La prima tratta con
rappresentazioni geometriche (“circoli”) “(…) il modo di cambiar
e ricambiar le mani per di fuora col Circolo ove il Cavalcatore
starà travagliando il suo cavallo”. |
|
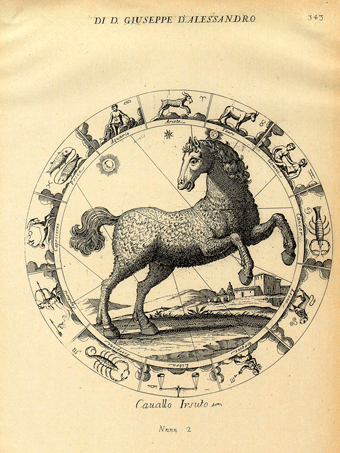
©
IMMAGINE DESCRITTIVA SUI TRATTAMENTI DI CURA PER IL CAVALLO, DA
“ARTE DEL CAVALCARE” |
|
Tale tecnica di equitazione, sostiene l’autore, è trattabile con
elementi di matematica, come avviene per l’attività di scherma.
Viene in questa parte dell’opera allora introdotto il suddetto
argomento, con descrizione delle varie mosse da fare con l’arma
“bianca”, dalla “sbracciata” alla “scoccata”, la “botta dritta”
e la “imboccata”. Vengono, poi, descritte cinque posizioni di
spada e pugnale (“guardia di sotto”, “guardia di sopra”,
“guardia per dentro l’armi” e “a mezza resta”). Diversi
tecnicismi, dimostra il duca Giuseppe, sono quasi simili in
equitazione e scherma. In merito vengono pure citate delle
lezioni del maestro di scherma, “maestro de’ Maestri”,
Sig. Giovanni Battista Marcelli.
Continuando in questo confronto,
vengono inoltre proposti sonetti dedicati ad un “perfetto
Cavaliere” e ad un “buon Schermitore”, così come al “cavallo” ed
alla “spada”. E’ intenzione del d’Alessandro dimostrare il
rapporto simbiotico esistente tra le due discipline, che fanno
capo alla cavalleria. Il perfetto cavaliere doveva essere capace
di condurre e mantenere un cavallo nonché a tirare di spada,
elementi questi alquanto enfatizzati dalla dottrina araldica
nello studio delle origine delle nobili Casate.
All’ideale figura del cavalcatore, cantata nel citato sonetto
con le seguenti rime: |
“Gran Domator del Generoso Armento,
Scelto Rettor de’ nobili Destrieri…
Con man leggiera, e col minor tormento
Sai ben frenar i docili, e gli altieri…
Col petto avanti, immobile, e costante
Con gamba assai leggiadra, e piè garboso
Reggi qual sia Cavallo strepitante…”
fa riscontro quella del “buon schermitore”, così descritto:
“Intento, e cauto a riparar se stesso,
Con se fatto Balestra di se stesso,
Il colpo scaglia, e poi torna in se stesso…
Con spada appropriata per se stesso,
Molti giochi propone, e fra’ se stesso…”
All’immagine esaltata del cavallo nelle note dedicate:
“Accorto imitator del genio umano,
Veloce Corridor, Corsier volante,
Attento Esecutor di dotta mano…
Rapido brio, che al Martial nitrito
Accordi il suon della tua man serrata…”
segue il sonetto alla spada:
“Gran Regina de l’Armi, Arme fatale
Ottima in Guerra, e necessaria in Pace…
Dell’Innocenza protettrice invitta,
Inimica de l’odio, e del livore
Sempre l’invidia fu da te trafitta…”.
|
|
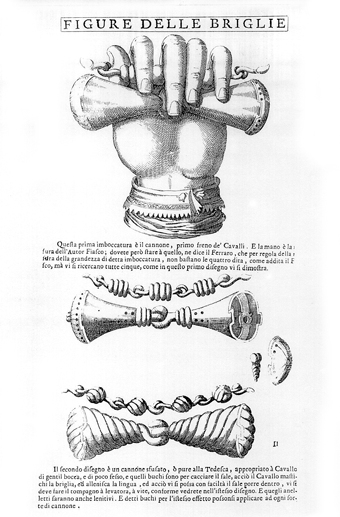
© IMMAGINE
DESCRITTIVA SULLE BRIGLIE DA "ARTE CAVALCARE" |
|
Questa tematica del cavallo e della spada, ricorrente nella
lirica seicentesca, viene proposta poi in alcuni madrigali,
quali quelli intitolati “Gloria del Cavalcare e Schermire”, “Bel
Cavaliero a Cavallo”, “Bel Cavaliero Spadaccino”, “Per chi brama
saper di Spada e Cavallo”).
Nel libro terzo, inoltre, il d’Alessandro passa ad una
presentazione di personaggi alquanto famosi nel Regno, gli
“Huomini Illustri”, di cui propone una scheda biografica e il
rispettivo ritratto. Tra i “Ritratti di Personaggi Eroici
intorno al mestiere di Cavalcare” figurano ben tredici famosi
“cavalcatori”, quali il Giovan Battista Caracciolo, Carlo
Miroballo, Oratio Carrafa, Paolo Franceschillo ed il citato
cavalier Giovanni d’Alessandro, zio del duca Giuseppe. Mentre
tra i tredici “Giocatori di Spada” figurano Marcello Lettieri,
Ottavio Caracciolo, Giovanni
Cicinelli, Carlo
Capecelatro ed
altri. Il terzo libro si conclude con una coloratissima “Ode per
il Torneo, che nelle funzioni Regali suol farsi nella Sala del
Regio Palazzo in Napoli”(20).
Quest’antica costumanza cavalleresca, ancora sentita ed
apprezzata nel XVIII secolo nel Viceregno spagnolo, viene
presentata in più pagine con specifica descrizione dei
particolari sull’avvenimento. Paragrafi quali sul “correr la
Lancia”, “dell’Anello”, delle “Regole per il Torneo” riportano
il lettore alle tematiche della ben nota letteratura
epico-cavalleresca. |
|
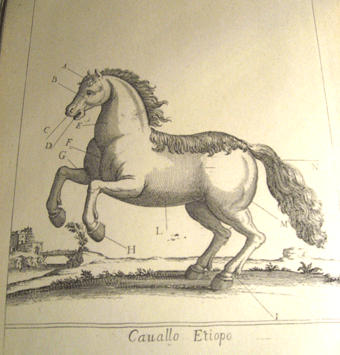
©
IMMAGINE DESCRITTIVA
DELLA TECNICA DI CAVALCARE, TRATTA DA “ARTE DEL CAVALCARE" |
|
In queste pagine del terzo libro
viene così descritta l’antica nobile usanza della Giostra con le sue
pompose parate, la sfrontatezza eroica dello sfidante, la presenza
cortese della donna.
Quest’ultima figura traspare nel
corso di tutta l’opera non solo per la costante presenza a
simili tornei, ma anche per la condivisa passione per l’attività
equestre. Non mancano, così, quei sonetti dedicati al
personaggio femminile, come nel caso di “Bella donna a cavallo”
o del “Cavallo frenato da bella donna”.
Infine, nel quinto libro l’autore tratta “intorno alla
Preservativa, Conservatione, e Medicina per Cavalli”. E’ la
parte più scientifica dell’opera, in cui si studiano ed
analizzano le diverse casistiche d’infermità del cavallo, nonché
i rispettivi rimedi medici, quale quello circa “i giorni critici
e buoni per salassare i cavalli” o lo “zoppicar del cavallo”, il
“ciamorro”, la “tosse secca”, la “colica”, la “storta”, la
“gamba rotta”, la “inchiodatura”.
Il trattato “Arte del
Cavalcare” termina con un sonetto dedicato alla “Nobile Gioventù napolitana”: |
“Di Partenope bella a l’armi, a l’armi
Incliti
Eroi, Superni Cavalieri,
Deh sul dorso guerrier de’ bei destrieri…
E che per voi la gloria impenn’il volo
A sparger fama eccelsa, e memoranda”.
|
|
Il 7 marzo 1713 risulta il duca essere a Napoli per affidare,
con atto legale a D. Giuseppe
Mezzacapo, procura a rappresentarlo
nel disbrigo di tutte “le liti e cause attive, passive, civili,
criminali(...) in ogni corte, luogo, foro ed avanti qualsivoglia
giudice, ufficiale e magistrato”.
Nel 1714, a seguito del successo ottenuto nel Regno, la sua
prima opera fu ristampata da Michele Luigi Muzio. Un anno
prima, invece, nel 1713 lo stampatore napoletano Felice Mosca
prese l’incarico di pubblicare un altro lavoro del duca Giuseppe
d’Alessandro, intitolato: “Selva Poetica”. Dedicato al viceré conte Daun, l'autore in tale
libro, assumendo un atteggiamento severo e pessimista, elevò note di
sdegno contro la società del ‘700,che a suo avviso stava
progressivamente abbandonando quelle virtù e costumi del secolo
passato. |
|
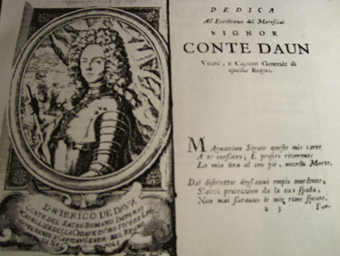
© FRONTESPIZIO OPERA
“SELVA POETICA” (Anno 1713) |
|
Il
duca-poeta subiva la tremenda insofferenza e noia di fin de siecle, con i suoi tramonti malinconici di un mondo che,
ora, popolavasi di gente opaca e tetra, di perfidi, pettegoli
(“raro è quel che non cela i fatti suoi”), di persone false ed
invidiose, di ingrati
di giovani oziosi (“nobil gioventù non si diverte in nobil
esercizi e nelle scienze”), di causidici(21).
Non è escluso neppure un “certo vecchio di cattivi costumi,
millantatore dell’antica sua stirpe”(22). |
|
Questa insofferenza pessimistica che traduce nelle righe del
sonetto “Per l’Umanità”:
“Nacque l’Uomo infelice in fragil polve,
che si disperde al respirar del Vento (…)
Ogni cosa qua giù diventa polve (…)”
e
tutta la tematica critica verso la società contemporanea
risultano argomenti tipici della produzione letteraria
seicentesca, con le sue forme barocche ispirate ad una “vena
sincera di tetra malinconia”(23).
Altresì, il duca nella sua opera attacca “(…)tutte le
argomentazioni cavillose e convenute, i sofismi, i
sillogismi(…)le ambilogie, le vulpecule, i cridalesimi (…) le
dispute di lana caprina, tutto l’immenso mondo astratto
dell’estrema scolastica aprioristica e deduttiva”.
Altri
sonetti della “Selva Poetica”, invece, scorrono con toni meno
negativi, poiché sono ricordati ed esaltati taluni personaggi
alquanto stimati ed apprezzati dall’autore, quali Giuseppe
Piccolomini principe di Valle, il virtuoso P. Frà Giuseppe
Parascandolo, Francesco
de Liguori, il Conte Daun, Francesco
Tomacelli e tanti altri. Tali sonetti e madrigali riferiti a
personaggi, usi e costumi di un’epoca contemporanea al
d’Alessandro costituiscono una ricca ed interessante fonte
d’informazione sulla società barocca di fine XVII secolo.
|
|
Di
detta società, egli non accettò quei costumi e le maniere della
moda francese, che negli allora lontani tempi stava
diffondendosi pure nella società italiana (la donna presente nei
trattenimenti civili e mondani; l'uso della polvere di Cipro che
rendeva l'aspetto dei vecchi più giovanile e viceversa).
Addirittura, nella “Selva Poetica” riguardo all’arte del
guerreggiare, il duca Giuseppe arrivò all'esaltazione di arnesi
ormai inutili ed armi emblematiche (cimiero, scudo, picca da
torneo, pugnale, spadone a due mani), sorpassate “dall'inferno portatile”,
quale lo schioppo.
Da queste pagine si evince come il duca amaramente accettava il
nuovo , non rassegnandosi all’idea di abbandonare le antiche
armi dei cavalieri, l’emozioni delle giostre, i nostalgici
tornei blasonati. Argomenti, questi, che ricordano passi
descrittivi del Don Chisciotte (1605) di Miguel de Cervantes
Saavedra.
Quel cavaliere del Cervantes, con vecchie armi e
l’elmo in cartone, il quale simboleggia quel mondo epico in
dissoluzione e dimentico della tradizione dei paladini, delle
crociate, l’armi, gli amori e cortesie, traspare nelle pagine
letterarie del duca d’Alessandro. |
|
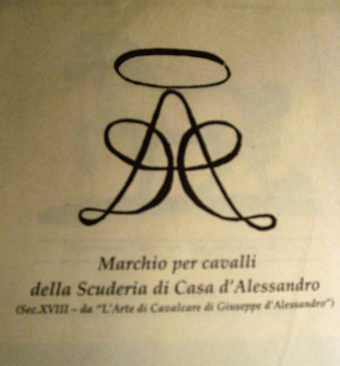
©
MARCHIO
USATO SUI CAVALLI DELLA SCUDERIA DEI d’ALESSANDRO PESCOLANCIANO |
|
In
particolare il Don Chisciotte si rinviene leggendo il madrigale
dal titolo “Contro l’Inventore del Schioppo”, in cui emerge
quella velata nostalgia di un mondo ormai tramontato nel XVIII
secolo, con l’avanzare del progresso tecnico e di una civiltà
improntata sulla polvere da sparo e sull’etica del profitto. Il
duca Giuseppe scrive:
“Pera chi fu’l primiero
A vomitar la morte
Da concavo metallo.
Se pria prode Guerriero
Incontrava la Sorte
Sovra nobil Cavallo
Co la spada a la mano,
Oggi inutil e’l suo valor
sovrano.
Malnata invenzione,
Che restringe l’Inferno in un
Cannone…”.
|
|
Lo
“schioppo”, prodotto dell’età “moderna” con i suoi nuovi valori
apparsi nelle società rinascimentali con la scoperta
dell’America, fu ritenuto dal d’Alessandro strumento accelerante
del processo di decadimento della tradizione cavalleresca di
antica origine nobiliare. |
|
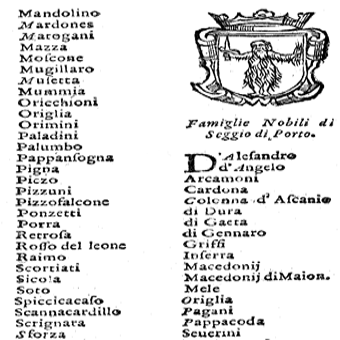
©
Iscrizione
del Casato al Sedil di Porto al tempo
del Duca Giuseppe |
|
Del resto il duca
Giuseppe apparteneva ad un illustre Casato che contava diversi
esponenti tra le fila dei cavalieri-baroni del Regno e che risultò
essere vicino sin dal XII secolo ad alcuni Ordini militari Cavallereschi.
Ciò spiega, pertanto, talune prese di posizione del Giuseppe
d’Alessandro, fedele ad una così antica tradizione di famiglia.
Nella
“Selva Poetica” non mancano, poi, i riferimenti inneggianti al
cavallo ed alla relativa attività equestre quali quelli
contenuti nei sonetti “Per un cavallo frisone”
o “Per il cavallo di Dario”,
“Per passare alla lancia a Cavallo”
ed infine “Per un veloce cavallo” e “Per quei ch’eternamente
lezzionano il Cavallo”. E’ poi interessante la presenza
nell’opera di alcuni sonetti moraleggianti su taluni costumi ed
usanze della nobiltà settecentesca partenopea, tali che “(…)
l’intelaiatura narrativa è press’a poco uguale a quella del
Giorno pariniano”.
Per taluni di questi argomenti trattati, difatti, è stato
ritenuto Giuseppe d’Alessandro tra gli autori precursori del
Parini. Il paragone verte sul citato sonetto “Alla polvere di
Cipro”, che fa ricordare la “(…) pariniana favola di Cipro”
pubblicata nel “Mattino”. |
|
La similitudine è maggiore nel
poemetto composto dal d’Alessandro sulla giornata tipica dei
nobili della sua epoca, con le loro eccessive abitudini sia
notturne (“verso la sera in tracannar sorbetta…”, dolci e
gelati), che diurne (“ritornate ver l’alba in vostra casa…”,
dopo le perdenti giocate con colazioni ad ore insolite,
l’imparruccarsi per la passeggiata). Alcune rime di detto sonetto sono:
|
|
“Verso la sera in tracannar
sorbetta
Acque gelate e frutta,
Con diversi canditi(…)
La notte intera a le
comedie,veglie(…)
Ritornate ver l’alba in vostra
casa
Talor tutti crucciati Per aver
perso al gioco
Ecco che giunta già del
cioccolato
E’ l’ora, e’l ripartier tutto
stordito(…)
Onde tosto che levasi la tavola
S’ode gridare: Cocchiero
Poni in ordine via su
Ch’il padron vuole uscire(…)
La perrucca s’accinge
E perché in casa più non v’è la polve(…)
Ed ivi a sberrettare
Inchini e baciamani
Prendete quante dame e quanti amici
Passeggiando incontrate(…)”
|
|
L’amareggiarsi per la fine di un’epoca e l’incapacità di
accettare il mondo nuovo è opera del “Tempo”, scandito - come
più volte menziona il duca Giuseppe- dal muoversi delle frecce
di orologi (“Per l’orologio ad acqua”, “L’orologio a sole”), dal
calare della sabbia nelle clessidre (“...gemin’urna di vetro in
se rattiene polve funebre...”)
o dal votarsi delle ampolline ad acqua (“…da racchiuso cristal
ciascuno apprende con chiarezza che l’ore del viver nostro son
brevi dimore...”). Nel 1714 il duca pubblicò l’ultima sua opera intitolata "L'Arpa
Morale", che a detta del Camporesi trattasi di “(…) uno stanco
libro di sentenze poetiche moraleggianti parafrasate in versi,
con aggiuntivi sei capitoli d’intonazione sermoneggiante”. |
|
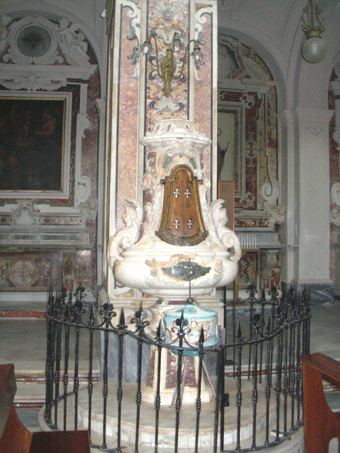
Napoli - Chiesa di S. Anna a Palazzo |
|
Un anno dopo l’11 agosto 1715 (come testimonia il reverendo
D. Gennaro Cappa coadiutore di S. Anna di Palazzo
(24)
,
nonché il decreto di Preambolo interposto dalla Gran Corte della
Vicaria del 13 agosto 1715), soggiornante nella sua dimora di
Napoli, lo colse la morte, quella che Giuseppe celebrò nel
sonetto “Col tempo tutto ha fine”, con queste parole: “(...)la
misera de l’uom vita vien meno(...)nè v’è chi creder vuole che
siam di passaggio e diventiamo alfine tributari di morte e
ruine”.
Nel 1723, otto anni dopo la morte del duca Giuseppe, il figlio
Ettore adempì ad una volontà testamentaria del padre(25),
facendo ristampare l’opera “Pietra di Paragone”.
Venne così pubblicata in Napoli da
Antonio Muzio, erede di Michele Luigi, la “Opera di D. Giuseppe d’Alessandro duca di Pescolanciano
divisa in cinque libri”.
Dedicata alla maestà di
Carlo VI
imperatore, re delle Spagne, a
cui il duca Ettore si rivolge nelle pagine introduttive per “(…)
onorar la mia Casa del Supremo suo Patrocinio”. |
|
L’opera venne riproposta in “quel
Dialetto, che il familiar ragionamento della propria patria
gl’aveva insegnato” per “farsi intendere da ogni genere di
persone, e letterate, ed idiote”. Infine, nelle pagine
introduttive viene ricordato che “(…) se i secoli passati, ed i
futuri hanno ammirato, ed ammireranno Alessandro d’Alessandro,
nel XVIII secolo ancora si sarebbe parlato di suo padre
Giuseppe. |
|
La ristampa del 1723, oltre a contenere i cinque
libri della Pietra di Paragone, venne arricchita tra l’altro con
altri componimenti letterari del duca Giuseppe ed altro
accademico. Risultano, pertanto, stampate nella parte finale
intitolata “Rime Diverse” numerose poesie tratte dai precedenti
lavori della “Selva Poetica” ed “Arpa Morale”.
Vi compaiono, ad
esempio, sonetti sull’Arte della Spada, tecnica gradita al duca
Ettore tanto da volerne un ampliamento del trattato. Al
riguardo, sono memorabili i poemi sul “Gioco di Spada sola
all’uso di Napoli”
o “Alla stoccata dritta”. Inoltre, in merito al suddetto argomento
vennero aggiunte nove tavole illustrative con “figure di positure di
scherma e d’altri Armi”.
Nella “lettera” che si accompagna a tali immagini con le diverse
spiegazioni sulle tecniche di combattimento si rinviene notizia
sulla provenienza di detti disegni. Scrive l’autore di aver conosciuto il
“(…)pittore, chiamato il Sig. Guglielmo Borremans, da cui avendo
comprato alcuni famosi quadri, ho avuto anche il piacere
d’alcuni disegni presi dal naturale intorno alle positure delle
Guardie della Scherma Napolitana”.
L’opera contiene, poi, una lunga rima
dal titolo “Gloria equestre”, dedicata a Nicolò Gaetano, che
riassume la storia del cavallo destriero presso diversi popoli e
civiltà (greca, etrusca, romana, barbarica). |
|
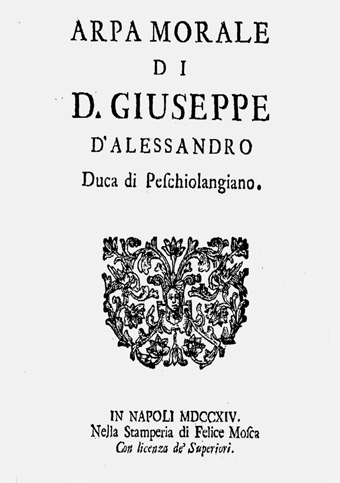
©
OPERA “ARPA MORALE” (Anno 1714) |
|
Dalle rime sul “Trattato d’imbrigliare” si passa ad una “lettera
ad un Amico” sul “nobile divertimento della Caccia” di lepri,
volpi e cinghiali con l’uso di armi, cavalli e cani. Trattasi di
una dissertazione che ricostruisce storicamente questa usanza
diffusa nei vari Regni. Altra “lettera”, invece, si rivolge più
specificatamente alla “caccia dello Schiedo, o Schiedone, che in
questo Regno suol praticarsi da alcuni Signori Cavalieri per lo
più nella Provincia di Lecce contro il Cignale”. Seguono rime
sulla “Gloria de’ cani” utili alla caccia. |
|
Seguono numerose rime che trattano svariate tematiche, quali
quelle sul “tabacco”, sul “caffè” o quella sulla “risposta ad
una Dama che domandò al Duca di Peschiolanciano per qual ragione
più non cavalcava”. Da quest’ultimo poema, si apprende notizia
sul duca Giuseppe, che in età avanzata non poté più montare a
cavallo a causa di “(…)un brutto umor mi fa’ cadere al piede”.
Compaiono, pure, alcune rime che trattano dei titoli onorifici,
quale “Illustre”, “Messer” o quello di “Cavaliere”, sul quale
viene scritto: “E’ cavalier chi prova i quattro quarti”,
ribadendo l’antica regola medioevale. Tra gli illustri cavalieri
del Regno, figurano citati Nicolò Mormile, Vespasiano
de Liguori, Giuseppe Caracciolo “utile Sig. della Terra di
Pettorano e gran Cacciatore”, Paolo
Dentice, Camillo
Pagano.
Seguono, inoltre, con maggiori dettagli alcuni nobili cavalieri,
signori di feudi nel Contado di Molise. Risultano, così,
pubblicati sonetti dedicati a Sebastiano Deboli (d’Eboli) barone
della Terra di Roccasicura, a Fulvio
di Costanzo principe di
Colle d’Anchise, ad Antonio Carafa “fratello del Sig. Duca di
Rionegro”.
Altri poemetti sulla “Pantera, Tigre, Lupo”, con rispettive
figure, riferiscono su questi animali. La sua passione per l’arte pittorica, di cui si è fatto cenno
riferendosi alla quadreria del castello, è confermata nelle
pagine di questa sua opera, in quanto esistono diversi sonetti
dedicati a noti artisti. Le rime più colorite sono quelle
dedicate “al Sig. Francesco Solimena i colori, ed alcune regole
della Pittura”, a “l’Egregio pittore Sig. Paolo de Mattei”,
nonché al Bassante e Caravaggio. |
|
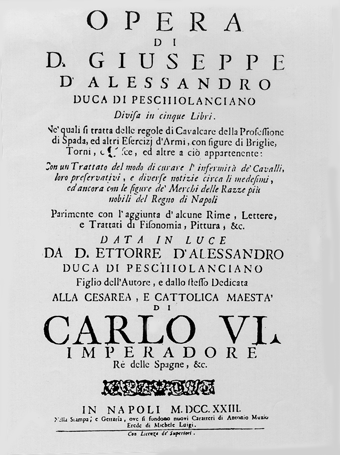
© Seconda edizione opera
“ARTE DEL CAVALCARE” (Anno 1723) |
Tutti questi componimenti poetici, comunque, contengono notizie
autobiografiche sull’autore sia quando trattano di passatempi,
di personaggi, di cose ma anche di luoghi. Infatti, alcune rime
sono dedicate a località frequentate e care al duca Giuseppe. E’
il caso del poemetto “Allo smisurato Monte Tottaro in
Pescolanciano”
o al “precipitoso fiume a costo alla Terra di Civitanova,
chiamato il Vallone, le di cui acque freddissime bevute
cagionano infermità, e spezzano qualsisia doppio Cristallo”.
Infine, è da menzionare il sonetto al “gran Poggio, da cavalcare
in Peschiolanciano, fatto così ridurre dall’istesso Autore, già
che prima era un Monte di Sasso, che poi ridotto in Poggi, hoggi
detto Poggio grande”. Tale poemetto fornisce interessante
notizia documentaria dell’intervento geo-morfologico fatto
eseguire da Giuseppe d’Alessandro al monte-sasso, ove trovasi
collocato il castello, al fine di rendere più facile l’accesso
pedonale o a cavallo.
|
|
Potrebbe, così, trattarsi di quella parte spianata, detta
“Varrata”, sottostante la rocca in direzione del cimitero di
Pescolanciano, così come lo stesso cortile del castello, di cui
si tramanda presso la famiglia d’Alessandro una composizione a
“gradoni”.
L’edizione del 1723 fu poi arricchita di una sezione contenente
“figure d’antichi celebrati personaggi con altre addotte per
dimostrativa della Somiglianza di varii animali”, prese
dall’opera di
Giovan Battista della Porta.
Infine, a chiusura del trattato furono inserite undici tavole
con impressi i marchi dei cavalli più illustri delle provincie
del Regno di Napoli, tra cui si evidenzia il Contado di Molise.
Tra i marchi molisani si rinviene quello del principe di
Salcito, del duca di Vastogirardi, dei Carafa di Campolieto, del
duca di Casacalenda, di Castel di Sangro e dello stesso duca di
Pescolanciano. |
|
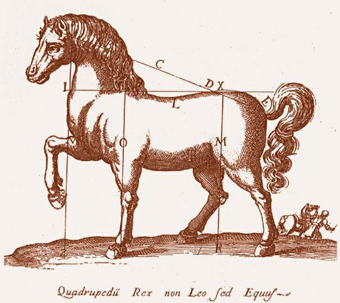
© Foto cavallo da
"ARTE
DEL CAVALCARE" |
|
Importante testimonianza della presenza in dette
località di allevamenti e scuderie di cavalli appartenute a
prestigiose Casate. |
|
Il duca Giovanni Giuseppe d'Alessandro ebbe dodici
figli:
1)
Agnese,
nata il
28/1/1695 † ?
2)
Agata,
nata
il
23/2/1697 a Pescolanciano, Monaca, †
3/11/1766
3) Francesca, nata
il
8/9/1699 a Pescolanciano, † 1771
4)
Ettore
5)
Marta, nata
il
20/7/1702, Monaca
6) Giulia, nata
il
13/4/1707 a Pescolanciano
7)
Isabella, Monaca
8) Nicoletta,
† 1717
9)
Serafina, Monaca
10) Margherita, Monaca
11) Consalvo, nato il
5/4/1705 †
14/5/1720
12)
Antonio |
|
___________________
Note:
1) Cfr. F.F. De Daugnon, La Ducal Casa
dei d’Alessandro, patrizi napoletani, Milano 1880,p.10; Giovanni
GETTO, Opere scelte di Giovanni Battista Marino e dei Marinisti,
Torino 1970, Vol.II.
2) G. Maselli, Come sorse la parrocchia
di Pescolanciano, Isola del Liri 1938, p.23 ; ARCHIVIO STATO DI
NAPOLI, Cedolario del Molise 1767-1806, ff.139-145.
3) Il Giustiniani (L. Giustiniani,
Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1797,
T.III p.287) riferisce del paese di Castel del Giudice ove “il
territorio produce tutte quelle derrate di prima necessità, e vi
sono luoghi addetti al pascolo di animali, onde i suoi cittadini
trovansi applicati alla pastorizia ed all’agricoltura. Non vi manca
caccia di lepri, di volpi, e di varie specie di volatili”.
4) C. De Raho, Peaplus Neapolitanus..patricias
illustresque familias continens, Napoli 1710, p.215. L’autore scrive
che “(…) Josepf Dux III Pescolanciani, egregius quidem vir, ac
praefatis castris et opibus potens, cui ditionem amplificavit uxor
Anna Maria Marchisana, domina Castri-Judici et Roccae Quinque Milium,
ex pervetusta Marchisanorum salernitana familia..”; ARCHIVIO STATO
NAPOLI (ASN), Cedolario Apruzzo Citra 1690-1791, f.413 tergo;
Cedolario Contado di Molise 1696-1731, f. 454 tergo. Anna
Baldassarre Marchesani risulta intestataria dei suddetti ultimi
feudi dal 1693 al 1731, in quanto iscritta nel Cedolario di Abruzzo
Citra per le tasse pagate: Roccacinquemiglia, ducati 9.3.15 e 14.3.4
nel Cedolario di Molise; Castroidicum, ducati 1.8.3/4.
5) L’ideale cavalleresco, tipico
dell’età feudale, era riapparso in Europa con la cultura spagnola
che aveva preso il sopravvento dagli inizi del ‘500 a seguito delle
conquiste territoriali. Questo ideale “classico”, esaltante lo
spirito militare e l’organizzazione autoritaria(che influenzerà la
stessa religione cristiana con l’istituzione della compagnia del
Gesù, milizia posta a difesa dell’eresia)con un forte senso di
devozione ed obbedienza, si diffuse inizialmente con difficoltà in
Italia, paese con tendenze anarchiche ed individualistiche, per poi
divenire appannaggio nostalgico nel ‘600,secolo di gravi crisi
socio-economiche e di valori in decadenza.
6) G. MASELLI, Op.cit., pp.18-19.
7) Antonino DI IORIO, Bovianum Vetus-
Pietrabbondante la viabilità antica, Roma 1994, pp.61-62.
8) Francesco COLITTO, La giustizia
penale nel Molise del ‘700, in Almanacco del Molise 1974, Campobasso
1974 ,pp.225-288.Il duca stesso promosse un giudizio contro il
suddetto comune per i danni recati al feudo di Castelluccio. Il
consigliere commissario, esaminate le prove documentarie addotte dal
d’Alessandro dimostranti la fondatezza della proprietà feudale su
quei terreni, ordinò il mantenimento del possesso a favore dello
stesso duca. Nel gennaio 1707 venne emesso il terzo decreto di
riconoscimento del possesso ducale delle terre di Scandiglieri e
Forconi (facenti parte di Castelluccio). Su Spelonca e Selvapiana si
dimostrò l’esistenza di relevi pagati, attestazione questa
confermante che trattavasi di proprietà feudale, facendo così
decadere le pretese del citato Comune, tendenti ad esercitare gli
“usi civici” (diritto di pascolare, acquare, legnare etc) su tutti i
fondi oggetto di controversia. L’8 marzo 1708 Giuseppe d’Alessandro
presentò,poi, istanza alla Regia Camera della Sommaria per la causa
di possesso dei terreni soprannominati della “Montagna”. A
conclusione di questa controversia giudiziaria il duca Giuseppe si
trovò, nel medesimo anno (1708), a pagare il relevio anticipato per
i feudi di Pescolanciano, Civitanova, Civitavecchia, Carovilli,
Castiglione. Per i feudi di Valle e Speronasino pagò ducati 300,
mentre per Castel del Giudice e Vicarre Piane 79.2.11 confermando
così la titolarietà delle suddette proprietà.
9) La congiura prese le mosse durante
il Vice-Reame di Medinaceli, gran sostenitore dell’ascesa al trono
di Spagna di Filippo V, ad opera di uno schieramento di nobili
napoletani, favorevoli all’Imperatore austriaco Leopoldo di Asburgo.
I nobili, capitanati dal giovane Don Iacopo Gambacorta principe di
Macchia da Barcellona e Don Girolamo Capece, intendevano modificare
lo Stato da provincia spagnola a regno libero, governato
dall’Arciduca Carlo figlio di Leopoldo. Nel settembre del 1701
scoppiò il tumulto con l’intento di uccidere il Vicerè, sollevare il
popolo contro le milizie spagnole ed occupare i castelli della città
fino all’arrivo delle promesse truppe imperiali. Il tentativo di
rivolta fallì per la scarsa partecipazione dei popolani, per i
contrasti sorti tra le file dei nobili congiurati e per l’arrivo di
un ingente milizia spagnola che espugnò i luoghi cittadini occupati
dai ribelli. Molti nobili congiurati vennero decapitati ed uccisi
nelle carceri ed il nuovo Vicerè duca di Ascalona ordinò il
sequestro di tutti i loro beni. (Cfr. Pietro COLLETTA, Storia del
Reame di Napoli, Ristampa, Trezzano 1992, pp.18-20).
10) Alcuni sonetti della Selva
Poetica sono dedicati a Hendl: “In te forte Campione or le mie vere
speranze fondo, E sol dal tuo favore Io mi vivo sicuro d’ottenere
giustizia, libertà, grazia, ed onore” (p.356).
11) ASN, Notaio Giuseppe Maddalena,
26 agosto 1712, Rif. 394/11, pp.314-331.
12) Riferisce il Giuseppe a p. 280
della Pietra di Paragone “(…)D.Giovanni d’Alessandro, Zio carnale
del Duca Fabio (Junior), mio Padre, hebbe per antecessore Fabio
seniore”. Di questi si riferiva il ricordo delle sue capacità
equestri e l’abilità a tirare di spada. Il Giuseppe, infatti, deve
aver saputo da qualche suo precedente familiare la storia, che si
tramandava nel casato, circa un celebre duello a cavallo in cui il
Fabio dette dimostrazione delle sue abilità e capacità, che insegnò
poi ai suoi diretti discendenti.
13) Piero CAMPORESI, Giuseppe
d’Alessandro poeta barocco tra Seicento e Settecento, in Convivium,
n.3, Torino 1952 Soc.Internaz., p.400.
14) Eustachio D’AFFLITTO, Memorie
degli scrittori del Regno di Napoli, Tomo I, Napoli 1782, p.211.
15) Lorenzo RUSIO, Opera de l’arte
del malscalcio, Venezia 1543. Trattasi di una delle opere più
antiche sull’equitazione, composte in latino dal Rusio, veterinario
di Orvieto, vissuto tra il XIII e il XIV secolo, con importanti
annotazioni sulle “molte malattie con suoi rimedi”).
16) Claudio CORTE, Il Cavallerizzo,
Venezia 1562. Opera divisa in tre libri, di cui il primo tratta
dell’origine del cavallo, razze e cure, il secondo dell’equitazione
e maneggio ed il terzo di dialoghi sul perfetto cavallerizzo.
17) Francesco LIBERATI, La
perfettione del cavallo, libri tre, Roma 1639. Si tratta “del
mantenimento del cavallo, dell’osservazioni la generazione, suoi
mali, e cure di essi, buon governo della stalla, qualità delle razze
antiche”.
18) Nicola e Luigi SANTAPAULINA,
L’arte del cavallo divisa in tre libri, Padova 1696. “Nei primi due,
che son di Nicola, si tratta l’arte di ridurre a tutta la
perfettione il cavallo. Nel terzo, che è di Luigi..vi si aggiunge il
modo di usarlo in guerra e in festa”.
19) Scrive il Giuseppe: “Anticamente
usavano in prima il capezzone in vece di ferro, tutto di corda; ma
dovevo supporre, ch’i cavalli erano più scarichi di collo, più
agili, più docili, e più leggierosi di testa” (Ibid., p.9).
20) Il sonetto così comincia: “Ecco
in ordin la Giostra, E a suon di Tromba l’onorata schiera De’
Cavalieri eletti Vestiti d’armi, e con chiusa visiera, Esce tutta
pomposa(…)”. G. d’ALESSANDRO, Op.cit., p.328.
21) Nel sonetto “Ad un cert’Uomo
Civile assai sporco pien di vizi, e perciò misero” sono riassunte
tutte queste considerazioni critiche dell’autore: “Tu, che sol vanti
d’essere ben noto, Ed hai la porcheria per consueta(…) Per dar ai
vizj l’ultimo tracollo(…)”, Ibid. p.28. Analogo tono si rinviene
nelle rime alla donna “col naso schiacciato” o alla donna “brutta,
che per esser maligna vive in continuo moto”, Ibid., p.34.
22) “O Pico tu sei vecchio e vanti
antica Progenie, e tutto ciò nessun tel nega (…) Dirò ben, che i
trafondati Tuoi con le gesta lor iniquie, e ladre Son puntualmente
in te tutti traslati”. Ibid.p.37.
23) Nelle liriche di quest’epoca il
tema della morte, del tempo, della meditazione dell’umana
condizione, rivelano un’epoca pensosa che evidenzia una condizione
di stanchezza spirituale, di sconsolata accettazione dei limiti
umani. D’altra parte si ricorda come il ‘600 fosse stato un periodo
di grave decadenza per l’Italia con crisi di valori (ignoranza,
superstizioni, processi di stregoneria, roghi di streghe erano
diffusi) ed ideali religiosi contrastanti (il cattolicesimo
integralista spagnolo in conflitto con il calvinismo francese),con
una grave depressione ed arretratezza economica (carestie del 1630 e
1657),con la peste che colpisce un terzo della popolazione
nazionale. Lo scenario politico è caratterizzato da continue guerre
per il predominio delle grandi potenze, la Spagna, la Francia (con
Luigi XIV, il re Sole) nonché l’Inghilterra e la dinastia Asburgica,
tutti stati europei in forte ascesa.
24) FIDE MORTIS, Elenco Chiesa S.Anna
di Palazzo, F.65.
25) Il figlio primogenito Ettore
Fabio (1694-1741) nato il 13 gennaio 1694, ebbe diritto al titolo di
IV duca di Pescolanciano ed erede “ab intestato” dei beni feudali
(come da fede dell’attuario G.C.Salvatore da Trito, nonché con
decreto di preambolo del 10 ottobre 1715).La successione alla
eredità di Giuseppe si svolse con fasi intercalate da atti notarili
dei coeredi. Il 13 agosto 1715 i figli “naturali e legittimi” del
D.Giuseppe, cioè il duca Ettore e D.Consalvo, vennero dichiarati
eredi universali e particolari dei beni burgensatici come da volontà
testamentaria del defunto. Essendo, allora, D.Consalvo in età
minorile, il fratello Ettore venne designato suo tutore, con
l’obbligo di garantire pure la dote a tutte le sorelle. La
successione, comunque, ebbe luogo il 22-25 ottobre 1715 presso la
casa palaziata di via Nardò con atto del notaio G.Maddalena di
Napoli.
|
|